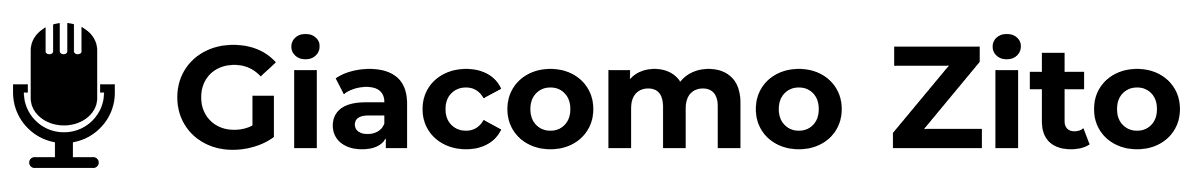Come galline a razzolare un po’ di graniglia gettata a caso. Cronistoria di un lavoro nobile svenduto per pochi danari.
Salta da una metrò all’altra seguendo ligio il cronometro dei turni del doppiaggio, dà disponibilità con whatsappini che rispondono a richieste improbabili tipo “forse c’è da fare uno speaker per uno spot, come sei messo fra mezz’ora?”, pianta overbooking di default che alll’ufficio biglietteria Alitalia negli anni ‘80 erano dilettanti. Miete disdette a sera e non ci fa neanche un antipasto. E caregrazie che gli mandano pure la disdetta, perché normalmente se ne fottono e intanto continua a saltare da un tram all’altro, ingollando acqua dalla borraccia per mantenere la regola dei due litri al giorno. Nello zainetto, oltre alla bottiglia, un libretto di teatro, il computer portatile, l’ombrellino pieghevole. Le frisk sono un optional che fa fico e non sono le cazzo di golia. Roba da pro. Se fa lo sborone si porta anche le cuffie perché la voce della pubblicità si sente meglio e chiede con non chalance un buco per ficcarcele dentro. (Questa roba fa godere i fonici che lo aiutano come se fossero wolfrisolvoproblemi)…
Nell’anticamera dello studio di registrazione non si usa nemmeno più il bacino di benvenuto, anzi, non lo cagano finché non si piazza li davanti con un sorrisetto storto da “certo che è sempre bello venire qui…” e costringe così la ragazza alla reception a smettere di maltrattare il mascara o di spalmarsi di marmellata la fetta, a dirti che ancora dentro c’è il vecchio cliente e quello nuovo non è arrivato. “Vuoi vedere il testo intanto?” Non gliene ne frega un cazzo del testo ma lo guarda come se fosse l’ultimo playboy uscito.
Tanto poi il cliente arriva con l’ultima versione dello spot da registrare: ventitré varianti da mettere nel cassetto che preludono a un’infiammazione alle corde vocali e il pensiero al prossimo appuntamento.
Prega che sia un farmaceutico che quelli a modificarli in corsa devi chiamare il padreterno che di dia l’approvazione quindi sei blindato e vaffanculo. Ma non è un farmaceutico e se proprio è un farmaceutico è l’imodium che non puoi nemmeno metterlo nello showreel perché tutti si sbellicano dalle risate: “ah sei quello dell’imodium”. Intanto incrocia il collega, la voce della pubblicità, anzi lo speaker pubblicitario, che ha appena fatto la BMW Xunnumeroacaso con i cingolati che spara obici da 400 millimetri addosso alle cinquecento dei vorrei ma non posso, bestie da due tonnellate che dovrebbero portarti in cima alle montagne. Lui, all’artista della voce, – che certamente non è arrivato in metro ma con quella Xunnumeroacaso che vuole già vendere per comprarsi quella nuova, vorrebbe dirgli che sta per incidere imodium, che gli è addosso, magari il suo carrarmato viene in tv dopo la sua diarrea e – insomma – è lì a un’incollatura, testa a testa, manca poco, prima o poi la ruota gira. E la ruota non gira perché lui la sente quadrata. Infila quelle cuffie personali, chiude la pesante porta dello studio, fa un cenno al fonico col pollice alzato. Si sgrana la voce davanti al microfono: “Facciamo stò imodium…”
Rossellini, un mostro.
Mi sveglio di soprassalto completamente fradicio di sudore, due occhiate in giro: sono nella mia camera da letto, la bocca impastata, il fiato un po’ corto. Quasi due mesi di Coronavirus e di fronte a me campeggiano i pannelli insonorizzati dell’home studio con il quale sto continuando a fare lo speaker da remoto. Le cuffie, le apparecchiature sulla console, il monitor… mi rotolo giù dal letto perché questo sogno – o incubo, sì: è un cazzo di incubo – lo devo mettere giù nel quadernino dei ricordi, o meglio nel mio blog, perché tutti sappiano che tempeste si agitano nella mia testa, cosa significa essersi innamorati follemente della propria voce al microfono che, più lo hai pagato, più non ne vuole sapere di ricambiarti, anzi ti disprezza e ti dice “dài, puoi fare di meglio, tutto qui, pivello? Sono un Neumann U87 e mi tratti così?”. Mi ero addormentato così felice guardando Il Generale Della Rovere di Rossellini con un superbo Vittorio De Sica e un parterre di attori da novanta (amo Sandra Milo e ancor di più Giovanna Ralli, ho amato la loro bellezza, la loro grazia, la loro personalità). Doppiato nel ‘59 da altrettanti attori che lavoravano al microfono quando io ero ancora nel mondo dei pensieri: Rosetta Calavetta, Fiorella Betti, Giorgio Capecchi, il mitico Glauco Onorato, un quasi esordiente Ferruccio Amendola. Un doppiaggio quadrato, preciso, scandito da una metrica, proprio come la sceneggiatura, impaginata con ordine, supportata da scenografie teatrali, le battute una dopo l’altra, nessuna confusione, l’ordine degli avvenimenti costruito come un’architettura. Tutto pensato per portare lo spettatore ben cotto al climax finale, quel riscatto che costa la vita al protagonista: il prezzo più alto per avere indietro la dignità e il rispetto del suo empatico antagonista tedesco.
Avrei voluto, anche solo per un po’, assaporare l’aria di quegli studi di doppiaggio, il rumore meccanico dell’anello di acetato magnetico che scorre sulle guide di macchine Western Electric importate dagli Stati Uniti, le porte pesanti degli studi di registrazione, con i pannelli forellati che ho visto solo nelle cabine telefoniche dell’albergo di montagna d’estate, quand’ero ancora bambino e le vacanze si facevano con l’oratorio (magari mi è venuta lì la passione per le sale di doppiaggio e di registrazione, vai a sapere…).
Avrei voluto assaporare il piacere di opporre le prove a teatro per non trovare il tempo di venire a registrare l’audio e di ricevere una richiesta subordinata tipo “quando mi trovi un momento per registrare la voce di quella reclàme?”. Avrei voluto provare la faccia di chi dice con tono vagamente aristocratico: “Voce di una pubblicità? Interessante, di che si tratta?”.
Se tutti sono a fare podcast, mi dici chi cazzo li ascolta?
E poi non ditemi che l’appartenenza a un’élite non esercita un fascino, che scalare i gradini della notorietà non rende un filo più piacevole questo nostro stare al mondo in coda col carrello della spesa vuoto nell’autodromo di un parcheggio dell’esselunga. Come le sceneggiature di Rossellini una volta il mondo era più ordinato: si capiva chi era il regista e chi faceva il doppiatore. Si capiva qual’era l’ordine delle cose, mica come adesso, dove chiunque è il broadcaster, produttore, interprete di se stesso, chiunque si mette a fare live sui social, chiunque si mette a fare un podcast. Mi dite chi cazzo li ascolta questi podcast se tutti sono lì a farli? Da voce della pubblicità mi fa strano accendere le macchine, fare i livelli, parlare via Skype con il cliente e registrare, pulire i respiri, ordinare le takes. C’era un metodo prima. E mi piaceva, come un bambino che quando gioca ha una sua sequenza nella testa, con i pupazzi di qua, i mattoncini di là, le scatole da riordinare quando la mamma chiama il pranzo è servito.
Mi sveglio di nuovo. Mi ero riaddormentato. In cinque minuti ho mescolato tutto: il microfono dell’home studio, il film di Rossellini, i tempi dello speakeraggio di spot prima del virus. Ma sì, alziamoci e facciamo un podcast!