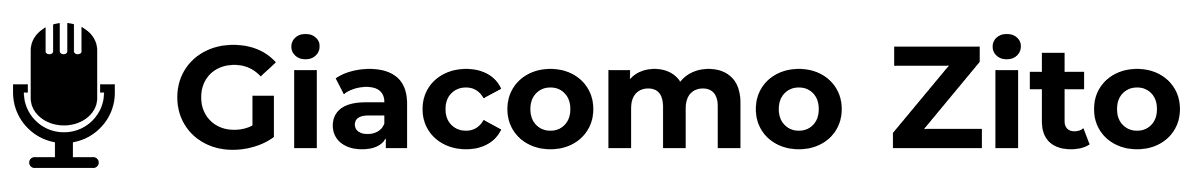Un microfono, un pop shield, un leggìo: tutti ricettacoli di virus!
Ho avuto anch’io il periodo della cuffia personale. Me la portavo ad ogni appuntamento, la sfoggiavo come ferro del mestiere, elemento capace di offrirmi comfort e sicurezza in ogni contesto. Insomma, una specie di copertina di Linus, nel mondo affamato di conferme e autostima come quello degli speaker della televisione. Non che ne fossi un reale appassionato: conosco colleghi e amici che collezionano cuffie e li capisco, sono oggetti bellissimi che hanno un rapporto diretto con il senso alla base del nostro lavoro di voci della pubblicità. La cuffia è un oggetto magico, perché racchiude un mondo immaginario nel quale potersi rifugiare. Ricordo la cuffia AKG regalatami un natale degli anni ‘80 da Pietro Fioravanti, impresario radiofonico di grande ispirazione: la conservo ancora, dopo averla orgogliosamente passata a mio figlio Riccardo. E ancora il pendente d’oro che il compianto collega disc jockey Gioele Campana si era fatto fare da un orafo, a simboleggiare la sua passione per la radio della quale era un fuoriclasse assoluto. E infine il piccolo monile regalatoci da Claudio Cecchetto alla nascita di suo figlio Jody, il cui nome – non vi sfuggirà – è la rappresentazione al contrario della parola deejay…
Siamo voci della radio, artisti che danno significato ai simboli, attribuiscono valore a oggetti e in questo caso la cuffia, come il microfono, rappresentano il nostro universo personale e professionale.
Divagare riporta a veder affiorare i ricordi. Ma questo articolo vuole affrontare un altro tema. Quello del futuro del nostro lavoro di voci famose della pubblicità, di come interagiremo, se basterà il piccolo vezzo di portarsi dietro una cuffia (temo di no e lo sapete anche voi) per risolvere due mesi di quarantena.
La necessità di mantenere dei presidi di sicurezza tra di noi, imporrà ad esempio l’utilizzo dei cosiddetti pop-shields (quegli schermi di calza di nylon per evitare le “P” esplosive davanti al microfono) che sono dei veri e propri ricettacoli di umori personali. Immaginate lo scambio di germi e batteri nello studio di registrazione: la superficie del leggìo, lo schermo, appunto, il microfono…
Finirà che noi voci del doppiaggio dovremo portarci appresso un armamentario di attrezzatura tecnica personale? Qualcosa di molto simile, probabilmente. Ma ciò che mi turba più di ogni cosa è la consapevolezza che l’interazione personale, quella che si attua tra l’autore, il copywriter e la voce della pubblicità, o tra attore e attore, difficilmente potrà ricrearsi in futuro nelle modalità che abbiamo sempre vissuto. Già da molto tempo, e per ragioni certamente non di carattere sanitario, l’interazione tra colleghi è stata osteggiata. Condividere l’emozione di uno script a più voci narranti, essere spalla a spalla nello studio con un o una collega ad aiutarsi con le intenzioni, i colori di un testo, è qualcosa che dà senso al nostro lavoro e che da diverso tempo ormai non mi capita più di sperimentare.
Ragioni di produzione, ottimizzazione, controllo del contenuto da parte dei produttori che “firmano” il successo di una campagna, hanno portato al nostro interagire all’interno di bolle individuali, a salutarci di sfriso nelle sale di attesa, a limitare le nostre interazioni, o tutt’al più coltivarle in incontri al bar dal sapore carbonaro.
Come gli attori, peggio che in teatro: la dimensione sociale del nostro lavoro è già sparita da un pezzo…
Stesso discorso per gli attori e il teatro, contesti che amplificano le difficoltà di vicinanza e prossimità imposte dal virus (ci credete che mi fa specie persino nominarlo?). I teatri che da millenni sono stati il luogo catartico della narrazione collettiva, che hanno unito classi sociali diverse in una condivisione di senso, dello stare insieme, del patto sociale, sono ora un luogo off limits, dove essere vicini per lo spettatore non è più un momento di scambio. Il teatro diventa un momento di separazione, di fruizione individuale. E allora perché non guardarci lo spettacolo dallo smartphone? Eccheccazzo!
No, troveremo la soluzione, troveremo una modalità alternativa per riprendere a guardarci negli occhi, certamente riusciremo a salvare il momento del confronto, dell’afflato passionale che guida i nostri obbiettivi, che ci domina e dal quale ci piace essere dominati. Anche noi voci della pubblicità siamo legati a doppio filo dal rapporto con il pubblico, sia esso rappresentato da un produttore, da un fonico, o dal team di un’agenzia di pubblicità nella sessione di registrazione della voce di uno spot. Viceversa non potremo più essere, dando spazio all’alternativa di una voce sintetizzata.
Senza pubblico e senza interlocutori. Siamo voci senza corpo. L’ultimo passo prima della sintesi vocale…
È questa la differenza che marchiamo rispetto alla realtà tecnologica di una bellissima voce come Siri o Alexa. La nostra capacità di interagire, di assorbire e restituire in una modalità analogica. E con questo intendo proprio far riferimento alla natura chimica degli scambi elettrici che avviene tra le nostre sinapsi, alla caotica e non prevedibile rete di connessioni che gestisce le nostre emozioni, i nostri ricordi, le nostre informazioni. Hai voglia a creare il miglior algoritmo per gestire i big data, ma la capacità imprevedibile del cervello umano è il segreto della nostra unicità e della differenza del nostro esprimerci artisticamente rispetto ai modelli di rappresentazione della realtà offerti dai sistemi informatici. Tutto il resto è… frattali (che io non trovo per niente affascinanti).
Insomma, l’espressione artistica non è un polimero che ricrea ad libitum la propria struttura. Siamo un valore per la nostra dimensione sociale, non dimentichiamolo in questo momento di isolamento forzato del quale – vi dico la verità – cerco i lati positivi ma adesso passiamo altro, ok?
Oltre il sindacalismo degli anni ’80, oltre la dimensione politica del mestiere, tutti in ordine sparso senza una visione comune.
Ho fatto in tempo a seguire alcune riunioni sindacali di attori e doppiatori anche della pubblicità per averne immediatamente a noia. C’era un elemento che mi affascinava in quegli incontri ed era la dimensione sociale di riconoscimento reciproco, il sentirsi legittimati ad essere “attori nel tempo” per parafrasare Mc Ewan, ancora una volta avendo a che fare con l’accettazione, l’autostima, eccetera. Ma allora ero troppo giovane per comprenderne il reale significato sociale, per riconoscere in ciò che facevo la dimensione politica, in senso nobile, s’intende. E così mi feci risucchiare dall’autocompiacimento, da una macchina economica che voleva le mie virtù tutte e subito ed era disponibile a pagarle a un prezzo che a me pareva incredibile, tanto scarsa era la considerazione che avevo di me. Disinvoltura e talento facevano il resto, rendendomi in pochi anni una delle voci della pubblicità e della televisione più gettonate di quel tempo. Ed ora, persa quell’unicità, ricompattato il valore della parola più che della forma, data la stura alla possibilità per ciascuno di essere “centro di produzione culturale e di contenuti”, che ne rimane del nostro bel mestiere?
Ancora vedo amici postare foto del microfono per eccellenza: il Neumann U87. Il padre di tutti i microfoni, quella capsula che, come uno specchio, impietosamente era capace di restituirti ogni imprecisione della tua parlata, così come rivelarti la bellezza della tua anima, come a dirti: “sì, anche tu, con la tua sensibilità, con il tuo valore, con la tua voce puoi dare un contributo a questo mondo apparentemente senza senso, nel quale fatichi a trovarti un posto. Dopo averne posseduti almeno tre, di cui uno del valore di un’auto (si, ero un pazzo), sono passato a un microfono artigianale da poche centinaia di euro, un Aston Origin che pare costruito in un garage, con pezzi di recupero. È un segno dei tempi. È un segno di consapevolezza. Consapevole che, con le mie cuffie, e al massimo con un “popshield sanificato”, tornerò per studi a salutare e riabbracciare le persone con le quali condividere uno dei mestieri più eccitanti del mondo: la voce al microfono.